

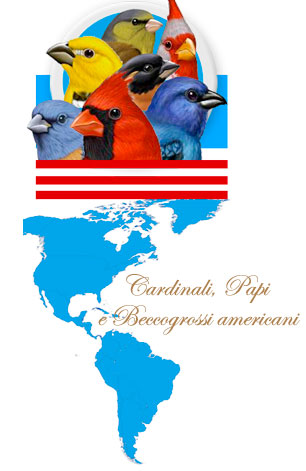
IL FROSONE BLU AMERICANO |
|---|
| La specie aviaria di cui intendo parlare appartiene alla famiglia degli emberizidi ed alla sottofamiglia, endemica del continente americano, dei cardinalinidi. Raggiunge una dimensione variabile tra i 15 e i 18 cm. a seconda della sottospecie di appartenenza o delle dimensioni individuali. Il genere Guiraca risulta essere rappresentato da questa sola specie (divisa in tre sottospecie riconosciute) poiché mostra, per gli ornitologi classificatori, caratteristiche peculiari ma che mio modestissimo avviso non sono tali da distinguerlo in modo apprezzabile da altri due generi Passerina e Cyanocompsa. Quanto al genere Passerina cui appartengono i ben noti papi e ministro, le affinità sono veramente molte e si riferiscono ai colori azzurro - blu, presenti in tutte le specie, alle caratteristiche comportamentali e di vocalizzazione, alimentari e nidificatorie, all’accentuato dimorfismo sessuale ed alla caratteristica, rara in uccelli di piccole medie dimensioni, secondo cui il piumaggio vivacemente colorato del maschio adulto viene raggiunto solo al secondo anno di età. Aggiungasi poi che in quasi tutte le citate specie, come pure nel genere Guiraca, il piumaggio del maschio adulto, subito dopo la muta (fase di eclissi), appare più o meno oscurato da una marginatura (“brinatura”) bruna-beige delle penne che fa apparire meno vivace il colore di base. Nel periodo degli amori, il logorio e l’abrasione dell’estremità bruniccia delle penne, fa si che i maschi appaiano nel loro tipico coloratissimo manto e, pur senza essere interessati da una vera e propria muta nuziale si assiste comunque ad un ricambio di piume nelle zone di elezione ed in particolare della testa collo e petto, laddove crescono nuove piume azzurro/ blu molto più brillante e totalmente privo di tracce bruno. Quanto al genere Cyanocompsa, diffuso nell’America Centrale e del Sud e decisamente poco conosciuto, eccezion fatta per l’Azulao (Cyanocompsa brissoni), anche per via dell’esigua bibliografia in merito, mi preme particolarmente sottolineare le evidenti affinità tra la specie Cyanocompsa cyanoides e la specie oggetto della presente trattazione. Avendo avuto la fortuna di possedere anche una coppia di Cyanocomsa cyanoides ho potuto direttamente apprezzare similitudini e diversità tra questi due “zigoli”. Il maschio di Cyanocompsa cyanoides, spesso chiamato ugualmente frosone blu (ma che ritengo più corretto identificare con il nome di frosone nero-blu o beccogrosso nero-blu, letteralmente traducendolo dall’inglese Blue-black grosbeak), ha dimensioni leggermente inferiori a quelle a della Guiraca ed in generale un piumaggio decisamente più scuro, blu notte, senza alcuna traccia di bruno marrone sulle ali. Possiede poi zone contrastanti sul colore di base, alla base del becco, sulla fronte e sulle spalle che risultano essere (se in buone condizioni e dopo la muta) azzurro brillante e costituite da penne leggermente lanceolate simili a quelle delle tangare.
Le remiganti e le timoniere, discretamente lunghe ma arrotondate sul vessillo esterno, sono nero cupo sottilmente marginate di blu. La coda è lunga e tondeggiante (simile a quella del merlo), l’intaccatura non è visibile se non in forma vestigiale, osservando attentamente le timoniere centrali che sono leggermente orientate verso l’esterno e così formando una lievissima intercapedine centrale. Nelle copritrici primarie e secondarie in rapporto nero/blu è diverso nel senso che il margine blu è decisamente più spesso, circondando il nero fino alla base (a mo’ di fiamma). La testa ed il becco (ma questo è leggermente meno curvo e più affilato), compresa forma e dimensioni e colore dell’occhio sono del tutto simili a quelle del maschio di Guiraca, pur essendo anche la mandibola inferiore “inquinata” irregolarmente di nero alla base. La femmina pur simile alla femmina della Guiraca appare tuttavia più scura, di un colore ancor più uniforme, superiormente ed inferiormente marrone bruciato brillante, con ali e coda bruno-nero marginate del bruno brillante dell’intero piumaggio. Il becco è poco più piccolo ricurvo di quello del maschio e totalmente nero lavagna. Spiccano, nella monocromia del piumaggio, che non presenta neppure le appena accennate striature presenti sui fianchi della femmina di Guiraca, le penne di contorno al margine superiore e inferiore dell’anello perioftalmico di un color bruno-arancio chiaro ed una lievissima sfumatura (non sempre presente) dello stesso colore sulla fronte. Nel piumaggio non vi è traccia alcuna, nemmeno larvata, di blu, nemmeno in esemplari anziani (caratteristica che le diversifica dalle femmine adulte di Azulao che invece, col passare del tempo, assumono sfumature azzurre su fronte, guance e spalle). Il richiamo, un penetrante e metallico “ciièph”, come una scudisciata, è del tutto simile nelle due specie che, alloggiate nella stessa stanza, si rispondono regolarmente. Il richiamo dei Guiraca è tuttavia meno prolungato con tono più lieve e dolce, alternato a volte da altro trillo (“ziip”) simile quello del frosone europeo (Coccotraustes Coccotraustes). Il comportamento generale delle due specie è molto simile, comune è l’abitudine, in stato di eccitazione o allerta, di dondolare lateralmente la coda, anche se le Cyanocompsa tendono anche a battere a scatti le ali semichiuse a mo’ di passero del giappone. La postura delle Guiraca è comunque più eretta e meno appiattita sul posatoio. Una grande prensilità dei piedi e l’abitudine di entrambe le specie di sostare in verticale sulle sbarre della gabbia conferma il comune adattamento a frequentare terreni erbosi (e canneti) disseminati di bassi cespugli. A differenza della Guiraca il maschio di C. cyanoides acquista il piumaggio dell’adulto già alla prima muta post natale e, probabilmente per la sua distribuzione geografica dove non esiste un vero periodo autunnale, il suo piumaggio non varia nel periodo riproduttivo. - Sono entrato in possesso di una coppia di frosoni blu del genere Guiraca il 9 di giugno del 2001, quando ne vidi alcuni esemplari presso un noto importatore del modenese. Scelsi un maschio, dei tre disponibili, con piumaggio ancora in gran parte giovanile ed una femmina, delle due detenute, che appariva più calma e pingue. Il maschio giovane fu da me preferito, a dispetto dell’aspetto decisamente meno attraente rispetto all’altro maschio adulto, nella consapevolezza che di norma, più un soggetto è giovane meglio si adatta alla vita captiva e più sono le possibilità di ottenerne la riproduzione. Il maschio, dicevo, mostrava una livrea dal tono prevalentemente bruno caldo più scuro superiormente, più chiaro ma più intenso inferiormente, tendente all’ocra-rossiccio sul petto. Evidenti nella regione dei lori, in quella auricolare e sul petto macchie turchesi irregolarmente distribuite, come pure azzurro, anche se parzialmente oscurato da una marginatura bruna, è gran parte del groppone. Nelle ali, evidentemente logore appaiono le remiganti. La coda lunga, arrotondata ma leggermente intaccata al centro (forcuta), quando è tenuta chiusa, viene frequentemente agitata in senso orizzontale da una parte e dall’altra. Tutte le timoniere mostrano la punta marginata di bianco sudicio-beige, decrescente in estensione dalle più esterne alle centrali, particolarmente visibile nel lato inferiore. pure le copritrici superiori ed inferiori della coda sono marginate dello stesso bianchiccio. Le timoniere viste da sopra sono bruno-nerastre lateralmente marginate, per circa 3/4 della loro lunghezza, di azzurro (visibile solo a distanza ravvicinata). Le spalle appaiono in vago color turchese-olivastro mentre i due ordini di copritrici primarie e secondarie formano due barre alari nocciola brillante, comunque discretamente individuabili nel bruno diffuso dominante nella maggior parte nell’ala (più scuro ed opaco). La barra più vicina alla spalla appare più spessa della seconda di circa un terzo e velata di color cannella. Il Becco è a forma di piramidale con base triangolare, massiccio e robusto ma non tozzo. La valva superiore è grigio chiaro (antracite-nera nel maschio adulto in amore), decisamente ricurva sulla superficie esterna, fortemente intaccata e angolata verso l’interno in prossimità della bocca, caratteristica peculiare degli emberizidi, come pure la convessità cornea all’interno della stessa. La mandibola inferiore, più spessa della superiore, è di colore grigio chiaro-corno-bianchiccio. Le zampe ed i piedi sono grigio-nerastro lucido. La femmina appare di corporatura più robusta e compatta, in qualche modo “più corta”. In prima approssimazione può essere paragonata ad una femmina di verdone in mutazione bruno (anche se di eccezionali dimensioni) ma ricorda tuttavia anche la femmina di ciuffolotto messicano (stessa mutazione). Di fatti il colore generale della femmina è bruno caldo come il maschio (giovane), tuttavia mostra il mento e la gola leggermente più chiari (bianco sudicio) oltre che a barre alari meno evidenti nel piumaggio generale. Ad un osservazione più accurata, è l’esatta copia ingigantita della femmina di papa Lazuli la cui unica diversificazione, oltre le ovvie dimensione corporali è la maggiore robustezza del becco (tuttavia differenza che si ridimensiona molto se si considerata il rapporto delle dimensioni in generale dei due volatili). Soltanto ad un’osservazione molto accurata e ravvicinata, in pena luce, si può notare una lievissima tonalità di grigio-azzurro olivastro, fortemente inquinato di bruno chiaro nelle zone di elezione e quindi sul groppone ed in modo leggermente più evidente sulle spalle. Ritengo che anche l’esemplare femminile sia in piumaggio giovanile stante le immagini delle femmine che ho potuto reperire che mostravano, nella femmina adulta, tonalità di bruno più contrastanti tra loro nonché zone di elezione decisamente azzurre anche se pallido ed opaco. Il becco leggermente più corto e decisamente più curvo, sulla parte superiore, che nel maschio e di colore carnicino chiaro soltanto lievemente velato di grigio scuro sulla valva superiore. Le ricerche bibliografiche e fotografiche da me effettuate, mi hanno permesso di determinare con esattezza l’età del maschio che, quasi certamente, ha un anno di vita. Di fatti lo splendido piumaggio blu del maschio adulto (su cui spicca la doppia barratura alare nocciola scuro-canella brillante) viene acquisito solo dopo la muta autunnale del primo anno successivo alla nascita. Durante la prima stagione primaverile-estiva successiva a quella della nascita, il giovane maschio presenta solo (come il mio esemplare) una variabile e disordinata pezzatura di blu sul piumaggio ancora prevalentemente bruno (una sorta di parziale pre-muta primaverile). - Gli esemplari in mio possesso poi, potrebbero appartenere alla sottospecie “interfusa”, propria della parte più orientale (ma non costiera dove invece predomina la sottospecie californiana, Guiraca caerulea salicaria) del sud degli Stati Uniti, caratterizzata rispetto alla specie nominata (Guiraca caerulea caerulea), da dimensioni leggermente maggiori, da un becco più massiccio, da una generale tonalità di blu più chiara e “polverosa”, vicina al celeste piuttosto che all’indaco brillante, sul quale risulta maggiormente evidente la piccola “mascherina” nera alla base del becco. Ribadisco, purtroppo, di non essere perito conoscitore di questa specie che vedevo dal vero per la prima volta, e che quindi l’appartenenza dei miei esemplari alla menzionata sottospecie è poco più che intuitiva, anche alla luce del fatto che il maschio mostra ancora il piumaggio transizionale. ALIMENTAZIONE Per alimentare i nuovi soggetti scelsi una dieta per quanto possibile varia. La base dell’alimentazione era costituita da scagliola e da riso vestito in parti uguali, con l’aggiunta di pochi semi di girasole (divorati con avidità). Quando disponibili aggiungevo piselli freschi e fagiolini sgranati dal baccello, con regolarità pastoncino all’uovo morbido e pastoncino per insettivori. Completo la dieta con quattro larve di tenebrione per ogni soggetto ma devo riferire che sia le pupe che l’insetto adulto sono molto graditi. Ebbi l’opportunità di fornire piccole ciliege selvatiche molto mature la cui polpa fu graditissima mentre il nocciolo debitamente scartato. Tentai di fornire anche “marusticani” divisi a metà ma questi, seppur non completamente disdegnati, non sortirono l’entusiasmo delle ciliege. Molto gradito è anche risultato il cuore dell’insalata lattuga. Due volte settimana somministro polivitaminico nella bevanda. ESPERIENZA DI ALLEVAMENTO La settimana successiva all’acquisto della coppia, provvidi a togliere il maschio dalla gabbia nella quale alloggiava con la compagna per via di un banale ferita all’ala che pensai tuttavia di curare con maggiore efficacia isolandolo. Nei giorni che seguirono ebbi l’opportunità di sentire il maschio cantare segno almeno probabile del suo stato di estro evidentemente raggiunto nonostante l’aspetto ancora parzialmente immaturo (si ricordi tuttavia che ritengo l’esemplare avere un anno abbondante di età). Il canto è estremamente potente e melodioso, in qualche modo irruente e prorompente, a mio avviso simile a quello del fringuello: è costituito da un susseguirsi di brevi note crescenti in volume ed intensità fino ad un culmine da cui decrescono in modo repentino. Il canto risulta comunque piuttosto breve e poco articolato, anche se estremamente gradevole, e viene ripetuto frequentemente ad intervalli di poco meno di un minuto. Sorpresi dopo alcuni giorni la femmina con nel becco materiale da nido probabilmente proveniente da una gabbia vicina e, anche se con poca convinzione inserii un nido a coppa per canarini nella gabbia fornendo inoltre abbondante e vario materiale da costruzione. Il giorno seguente notai che tutto il materiale messo a disposizione era stato spostato ed in parte trasferito nel nido! Provvidi conseguentemente ad infrascare sommariamente le parti della gabbia limitrofe al nido con rametti di rovo e di cipresso. Dopo due giorni la femmina aveva completato il nido, lasciando tuttavia sul bordo, a ”penzoloni” una grossa “lingua” di cotone idrofilo. Dalle ricerche da me effettuate avevo comunque appreso che questi “beccogrossi” solgono costruire il nido su cespugli o arbusti a poca distanza dal terreno, decorandoli in svariati ed eccentrici modi come con l’ausilio di pezzi di giornale, pelli di serpente, cotone idrofilo ... A questo punto mi decisi a reinserire il maschio nella gabbia (comunque di dimensioni medio-piccole ma schermata su tre lati). Devo premettere che la femmina emetteva in continuazione sommessi richiami (simili a quelli dei merli sul terreno ma più dolci e soffocati) alzando testa e coda verso l’alto, mentre abbassava e faceva vibrare le ali. Aggiunsi osso di seppia grattugiato grosso e suoi frammenti al cibo. Eccezionale a dirsi! Stanti gli espliciti inviti della femmina il maschio da subito apparve assumere una postura diversa: piumaggio tenuto molto aderente al corpo, penne della testa sollevate a mo’ di ciuffo erettile (proprio di molti cardinalinidi e zigoli ma non visibile nel frosone blu se non in stato di eccitazione), coda divaricata ed in moto perpetuo. Anche i vocalizzi erano cambiati, l’usuale richiamo forte metallico sostituito da un trillo “trascinato” (t-rr-rr-rr) simile a quello del verdone anche se decisamente meno prolungato e sonoro. Seguirono, in soli 25 minuti di osservazione, ben sei tentativi di accoppiamento!! Di cui, a mio avviso, solo due probabilmente andati a buon fine. Interessanti sono state le modalità dell’accoppiamento: ogni tentativo veniva posto in essere su espresso invito della femmina, il maschio, che non ha mai mostrato iniziative autonome, si avvicinava in volo alla femmina mantenendosi sempre sollevato anche se appoggiava delicatamente le zampe sul doso della compagna (ho potuto successivamente osservare pressoché identiche modalità di accoppiamento nei ministri Passerina cianea). Dopo ulteriori due giorni, in data 30/06/01, la comparsa del primo uovo nel nido. Le dimensioni sono circa di una volta e ½ quello di un canarino ma la forma è decisamente più allungata e affusolata ma non appuntita ed anzi “smussata” e tondeggiante anche nella parte più sottile. Il colore è azzurro chiaro brillante senza alcuna macchia. Seguiva il giorno seguente un secondo uovo. Stante il comportamento molto agitato del maschio e le modeste dimensioni della gabbia giunsi alla sofferta decisione di separarlo nuovamente. Non ho potuto monitorare ulteriormente il nido a causa dell’inizio della cova da parte della femmina che mi sono ben guardato dal molestare. Solo successivamente, in data 5/7/01, approfittando di un breve uscita della femmina dal nido per alimentarsi potei constatare che le uova erano rimaste due e che quindi la covata (probabilmente per la giovane età della femmina) non era costituita dalle quattro uova proprie della specie. Nello stesso frangente, scorsi tra le foglie secche sistemate sul fondo della gabbia, in prossimità del nido, un terzo uovo intatto probabilmente il primo deposto in quel luogo. Detto uovo era tuttavia deforme, di una dimensione di circa la metà delle altre. Pur quasi certo della sua non fecondità, lo introdussi ugualmente nel nido. Osai sperare un uovo solo il giorno 10/07/01, approssimandosi secondo i miei calcoli e le mie speranze la schiusa. Lo feci sollevando con estrema lentezza e delicatezza la femmina dal nido dal quale beccandomi energicamente non si allontanò neanche per un istante. Guardai l’uovo prelevato contro luce non disponendo di una lampada adeguata. Appariva assolutamente pieno ed opaco, con un riflesso perlaceo, anche se lo spesso guscio non faceva trasparire alcunché. Dopo pochi secondi lo rideposi nel nido con le stesse modalità con cui l’avevo prelevato. Lo stesso giorno mi decisi a rimettere assieme la coppia. Aggiunsi poi alla dieta come sopra illustrata spighe di panico e di sorgo ancora verdi (queste ultime oltremodo gradite) oltre che semi per esotici germogliati in poca acqua. In data 11/7/01, rinvenni il piccolo uovo sottodimensionato galleggiante nella vaschetta per il bagno. Osservatolo alla luce, in quanto straordinariamente ancora intatto, risultò essere oltremodo trasparente ma la cosa non mi sorprese. Il 13/07/01, con grande emozione, scorsi nel nido due pullus, le dimensioni erano leggermente maggiori a quelle dei p. di canarino, in particolare la testa appariva più grossa e pesante. Sono completamente rosa-carnicino, nudi eccezion fatta per uno scarsissimo piumino grigio chiaro su testa ali e schiena. Il becco era già relativamente grande, carnicino-bianchiccio e ben formato con carnucole angolari gialle nella parte interna, bianco gialliccio in quella esterna (sulla sua sommità è ancora evidente il “dente” per la rottura del guscio), l’interno della bocca è rosa acceso. Il gozzo è vuoto mentre la femmina provvede ancora alla cova. Ho fornito in aggiunta alla dieta camole del miele e piccoli lombrichi. Ancora una volta, stante il suo stato di grande nervosismo e irrequietezza, separai il maschio. Il 16/07/01 potei constatare che i pullus erano notevolmente cresciuti, in particolare le zampe e i piedi apparivano più lunghi, attraverso la pelle delle ali si intravedevano le capsule scure delle remiganti non ancora spuntate, il ventre molto gonfio e rigido il che mi fece pensare a problemi di digestione probabilmente dovuti all’alimentazione troppo pesante. In particolare il soggetto più piccolo evidenziava un fegato grosso ed indurito. Mi decisi così a somministrare un preparato antibatterico nell’acqua della bevanda. I piccoli apparivano comunque decisamente pingui ma immaturi e deboli e scoordinati nei movimenti con occhi chiusi. La madre covava assiduamente i pulli e non appena fornivo nuovo cibo vivo, usciva dal nido e si precipitava a nutrirsene. Ho rilevato che veniva scartato ogni cibo che non fosse di origine animale eccezion fatta che per un po’ di insalata. Più graditi dei tenebrio risultavano essere “le camole del miele” che venivano schiacciate dalla madre all’interno dei becchi dei piccoli. La madre durante la nutrizione si poneva sul bordo del nido reclinando il capo all’interno dello stesso. Approfittando delle brevi assenze della madre, genitrice scrupolosissima, osservai che il nido era assolutamente pulito, senza traccia alcuna di escrementi o residui di cibo. La femmina di frosone infatti provvedeva a prelevare gli escrementi dei piccoli man mano che uscivano dalla cloaca per poi collocarli al di fuori del nido. I piccoli, dal canto loro, trattenevano le deiezioni fino a quando non avvertivano/vedevano la presenza della madre nel nido. La madre apprezzava moltissimo anche i comuni grilli che, quando nel nido, accettava dalla mia mano senza troppe remore. Dovetti recarmi ben tre-quattro volte al giorno per rimpiazzare il cibo vivo letteralmente divorato. Il sesto giorno (18/7) potei osservare che i piccoli erano decisamente più vitali e si sporgevano dal nido con il collo rigido ed il becco spalancato chiedendo insistentemente cibo con un costante pigolio. Il cibo vivo non era mai abbastanza!! Sulle ali e sulla schiena erano già spuntate le capsule delle remiganti e delle penne del dorso di colore molto scuro. Sui fianchi stavano spuntando altri ordini capsule di colore chiaro. Gli occhi erano già parzialmente aperti. Ritengo interessante fare alcuni cenni sul comportamento nutricatorio della femmina di Guiraca da me osservato. Una volta messo a disposizione il cibo vivo la femmina ne inghiottiva gran parte uccidendo il restante. Successivamente, facendo ritorno al nido, imbeccava i pullus con le ultime larve ancora trattenute nel becco. Di seguito, man mano, rigurgitava altre larve precedentemente inghiottite intere. Il 20/07/01, procedetti ad inanellare i piccoli diametro C), anche se constatai, vista la grande difficoltà dell’operazione, di essere un po’ in ritardo. La femmina saggiava la sazietà dei piccoli ponendo il cibo all’interno del becco di uno di essi, se era lento nel deglutire, lo estraeva per porlo nel becco dell’altro. Le soste della femmina nel nido per covare i piccoli erano divenute decisamente meno frequenti e più brevi. La stessa comunque covava regolarmente i piccoli per tutta la notte, dopo essersi collocata nel nido ancora bagnata dopo un bagnetto al tramonto. In data 23/07/01, i pulcini apparivano ormai completamente impiumati e sostavano sul bordo del nido guardando con interesse l’attività della madre. Le remiganti erano ancora corte, incapsulate per circa 1/4 della loro lunghezza, mentre le copritrici delle ali evidenziavano già chiaramente le due barre alari più chiare. La testa era ancora prevalentemente ricoperta di capsule appena spuntate, mente solo sulla nuca vi erano già vere penne di colore di bruno-rossiccio scuro. I fianchi erano già ricoperti di penne ocra caldo ma non coprivano ancora totalmente lo sterno. Le timoniere e le copritrici della coda, seppur completamente spuntate, apparivano tuttavia molto immature. Le zampe già molto sviluppate e più forti erano divenute grigie rispetto al rosa carnicino della nascita. Osservai la femmina ricominciare a nutrirsi di alcuni semi di sorgo immaturi in spiga e piccoli frammenti di prugna selvatica. Il consumo di alimento vivo era aumentato a 36 larve di tenebrio più 18 camole del miele al giorno. La mattina del 25/07/01 (dodicesimo giorno) sorpresi entrambi i piccoli sui posatoi della gabbia al di fuori del nido. Apparivano abbondantemente impiumati ma le loro dimensioni erano di circa la metà di quelle della madre, il loro colore, nelle parti già complete del piumaggio, pressoché identico a quello della genitrice. Appena si accorsero della mia presenza si buttarono dal posatoio sul fondo della gabbia e se ne stettero immobili con evidente finalità di mimetizzarsi con le foglie e le frasche. Non erano ancora propriamente in grado di volare ma potevano reggersi bene in equilibrio e arrampicarsi con relativa agilità usando zampe e ali. Potevano altresì fare piccoli balzi coadiuvati da un non ancora rapidissimo battito d’ali. Il becco dei piccoli era lungo ma relativamente sottile e tenero e di colore grigio chiaro rosato, assolutamente inadatto a rompere semi. L’abbandono a mio avviso un po’ prematuro dal nido (me lo sarei aspettato almeno un paio di giorni dopo), probabilmente fu dovuto alle sue dimensioni troppo ridotte ed al caldo afoso di quei giorni. Più tardi, durante un mio accesso per fornire cibo vivo, constatai che i piccoli avevano fatto ritorno al nido sui bordi del quale sostavano sonnecchiando. I piccoli emettevano un richiamo simile a quello degli adulti ma più dimesso e meno e metallico. In data 30/07/01 i piccoli erano già in grado di compere brevi voli e mostravano di essere molto sicuri ed agili sulle zampe manifestando un comportamento piuttosto forastico. Il capo era già perfettamente impiumato mentre il mento e la gola apparivano ancora nudi. Le remiganti secondarie molto lunghe, le primarie ancora brevi incapsulate per gran parte. Le timoniere brevissime ma con estremità espansa, rimanevano perennemente divaricate a mo’ di piccolo ventaglio. Per chiedere cibo vibravano le ali chiuse e la testa con il becco spalancato emettendo un forte ma breve grido simile a quello emesso dai piccoli di storno. Il 02/08/2001, a venti giorni dalla nascita, i piccoli mostravano grande disinvoltura e motilità all’interno della gabbia, sebbene l’incremento delle dimensioni non fosse grande. Dovetti infatti constatare un’accrescimento sensibilmente più lento da quando i piccoli avevano abbandonato il nido. Anche la massa grassa appariva decisamente diminuita in particolare in un soggetto (poi rivelatosi maschio). D’altra parte tuttavia le remiganti e le timoniere erano divenute più lunghe e ordinate ma le penne del mento e della gola in gran parte ancora assenti. Osservando nelle mie mani in piena luce i soggetti constatai che uno di essi mostrava, nel tratto da poco spuntato di timoniere e remiganti secondarie, una sottilissima marginatura blu-grigia, non visibile che a pochi centimetri di distanza. L’altro soggetto aveva i margini delle penne nelle zone corrispondenti color marroncino chiaro, mi resi conto quindi che i nuovi nati erano di sesso diverso e che, dunque, dato da me mai riscontrato in alcuna bibliografia, in questa specie si manifesta un lievissimo dimorfismo sessuale anche nella prima livrea post-natale. In entrambi i soggetti che ancora non avevano minimamente iniziato a nutrirsi in modo autonomo, erano ancora evidenti ai lati del becco le carnucole divenute ormai completamente bianche. Il becco, decisamente ispessito ed indurito, era di color grigio medio su entrambe le valve, come pure dello stesso colore sono diventati pedi e zampe. In data 8/08 la femmina cominciò a mostrare intolleranza nei confronti dei piccoli. Gli atteggiamenti dapprima solo minacciosi finirono nel giro di alcuni giorni per diventare vere e proprie aggressioni ai danni della prole. Mi vidi costretto a separare i piccoli dalla madre nonostante mi rendessi conto che non erano ancora del tutto indipendenti. Per di più durante le operazioni di trasloco mi feci sfuggire la preziosa genitrice che perdetti per sempre. Dovetti quindi integrare l’alimentazine dei piccoli fornendo loro personalmente 5 camole del miele 3 volte al giorno. L’operazione era resa più difficile per il fatto che i piccoli non aprivano spontaneamente il becco ma mi permise man mano di rendere i giovani sempre meno paurosi e più docili. I soggetto più piccolo mi diede seri pensieri e lo vidi particolarmente in difficoltà l’11/08, quando dimagrito all’osso, mostrava un comportamento letargico con penne leggermente arruffate. Tuttavia martedì 15/08 scorsi entrambi i piccoli mangiare da soli e li ritenni tutto sommato svezzati. La difficoltà successiva che dovetti affrontare fu quella di abituarli ad ingerire semi secchi e non solo camole e pastoncini (all’uovo e per insettivori). Già in data 28/08/2001 potei notare che i giovani iniziavano la parziale sostituzione avente da oggetto le timoniere centrali e le remiganti terziarie. Più che di una muta precoce, che si arrestò in un paio di settimane, ritengo tuttavia si trattasse della semplice sostituzione di penne i due giovani, litigiosissimi, si erano strappati reciprocamente. Nel soggetto che già ritenevo essere di sesso maschile, le nuove penne, più grandi e robuste delle sostituite, presentavano una marginatura blu ancora più evidente. La femmina mostrava nelle rispettive penne una marginatura beige-olivastra. In entrambi i soggetti si poteva constatare anche l’incremento delle piume di tutto il mantello e ciò conferiva loro una sagoma più compatta e robusta. In particolare sul groppone del maschio spuntarono penne azzurrogolo-olivastro-grigio spento marginato di beige, analogo colore si evidenziò ben presto anche sulle spalle tuttavia più marcatamente bluastre. Nella femmina le medesime zone divennero beige-grigiastro. La muta riprese in modo consistente a partire dalla metà del mese di ottobre. I giovani ed il padre collocati assieme ad una nuova femmina adulta, divennero con l’autunno più docili e mansueti oltre che incredibilmente grassi, circostanza che mi indusse ad alleggerire la dieta. I giovani nati, in particolare abituatisi alla dieta granivora mostrarono di gradire oltremodo fettine di mela e uva che somministravo in piccoli grappoli otre alle bacche di “sorbo dell’uccellatore” attaccate al rametto. A seguito della muta autunnale, come mi aspettavo, il padre assunse il noto colore blu uniforme ma nettamete oscurato dalla “brinatura” della parte apicale delle piume di color bruno beige, tipici della veste invernale. Noto che le timoniere sono decisamente più larghe delle precedenti, i loro margini inferiori e superiori mostrano macchie apicali bianco latte (non più beige). Il loro margine esterno è di color blu vivido e decisamente spesso (3 mm. circa) su un color nerastro di base. Nel margine inferiore di quelle centrali il passaggio dal blu (più opaco) al nero è diviso da una pregevolissima ulteriore marginatura grigia. Dalle mie osservazioni relative all’allevamento in cattività della Guiraca caerulea ho potuto constare, circostanza di cui, tengo a ribadire, non ho trovato menzione alcuna nella bibliografia da me consultata, che il dimorfismo sessuale seppur in modo appena percettibile si manifesta già nel primo piumaggio giovanile. Maschi e femmine giovani mostrano comunque una tonalità leggermente diversa di bruno: più scuro e rossiccio dei maschi ed in modo maggiore nella barra alare più prossima alla spalla, più chiaro tendente al camoscio nelle femmine. La barra alare più prossima alla spalla è nei maschi più larga, più stretta nelle femmine, occupando solo 2/3 della superficie di ogni copritrice (sul versante esterno e non l’intera copritrice stessa come nei maschi appunto). Le copritrici caudali dei giovani maschi poi, sono grigiastre (bluastre) e marginate di beige-bianco, quelle delle femmine bruno chiaro marginate di beige. Successivamente alla prima muta (parziale) giovanile diviene decisamente più evidente anche se dubito fortemente possa comunque essere rilevato da un osservazione di soggetti in libertà anche a distanza relativamente ravvicinata. Solo nella primavera successiva a quella della nascita i giovani maschi mostrano irregolari pezzature blu della stessa tonalità di quelle dell’adulto e ciò permette già un’inequivoca distinzione dei sessi. Con la muta del secondo autunno viene raggiunto il completo piumaggio del maschio adulto con la massima espressione della diversità tra i sessi. Filippo Montaguti |



